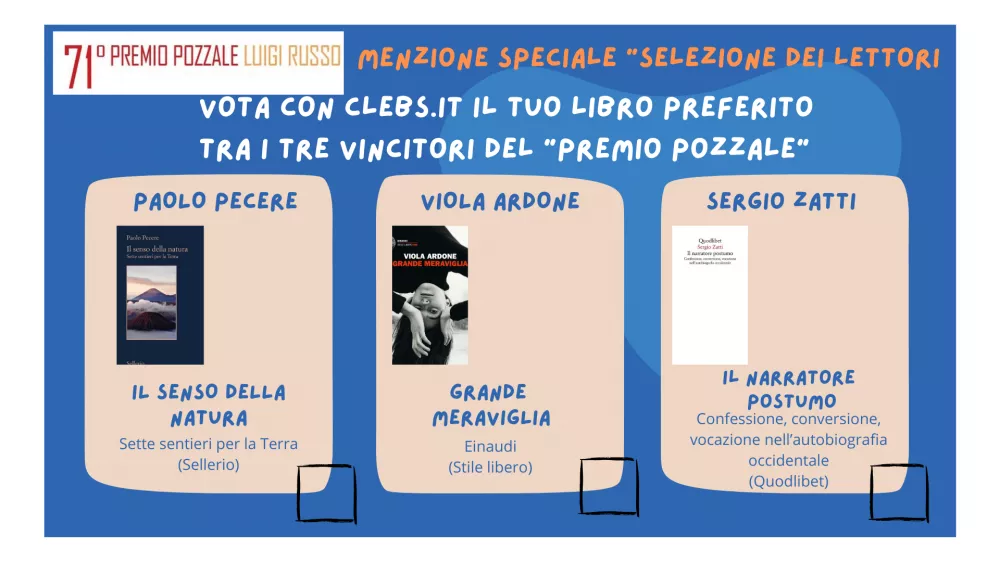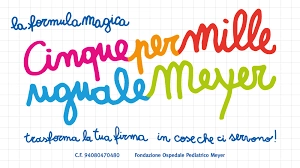Tempeste sempre più frequenti: come i cambiamenti climatici modificano durata e intensità dei temporali invernali
15-02-2025 17:27 - Opinioni
di Gordon Baldacci
Il termine temporale indica un fenomeno che, come dice l’etimologia stessa del termine, dura poco, un fenomeno appunto “temporaneo“, di breve durata. Ci sono però temporali che sono tutt’altro che di breve durata. Temporali che nascono e si rigenerano sempre lungo la medesima direttrice e pertanto vanno ad interessare sempre le medesime zone, per ore ed ore. Ma come può un temporale stazionare su una certa zona per tanto tempo e soprattutto, da cosa nasce. Ci sono due casi: il primo è legato alla presenza di una cosiddetta multicella autorigenerante. Questo tipo di temporale si innesca quando in quota soffiano forti venti ad alta quota. Se la direzione di questi venti in quota è opposta alla ventilazione nei bassi strati, vuoi per ricaduta di aria fresca dalle vallate montane, vuoi per un asse fortuito generato anche su zone di pianura o di mare, ecco che la nostra cella temporalesca può contare sopravvento alla nascita di nuove celle che poi vengono dilatate nella direzione del vento in quota e portare abbondanti piogge lungo la parte sottovento. Il processo termina quando viene meno una delle cause che lo sostiene, ad esempio, quando cambia l’asse dei due venti (non più contrapposti), o quando l’area di pescaggio iniziale non ha più sufficiente ricarico caldo-umido né energia per l’ulteriore sostentamento del temporale.
Il secondo caso avviene quando invece in quota e al suolo la ventilazione è pressoché assente. Se la colonna d’aria è instabile e nei bassi strati si trova molta umidità, possono innescarsi celle temporalesche. Inizialmente queste celle sono singole, ma ben presto si uniscono a formare un sistema convettivo quasi stazionario. Le celle vecchie infatti fanno ricadere aria fredda verso il basso provocando il sollevamento dell’aria calda e umida presente nei dintorni e quindi lo sviluppo di nuove celle nelle aree immediatamente circostanti. Il processo termina quando termina l’energia a disposizione, ovvero quando tutta l’aria calda è stata sollevata, e l’umidità utilizzata per le precipitazioni.Quindi abbiamo capito che per (semplificando) far creare queste piroette nell’atmosfera e mantenere il …giro di walzer…, servono forti contrasti termici. Fatta questa deduzione, andiamo a vedere cosa stava accadendo in questi ultimi giorni sia a livello atmosferico che sulla terraferma, mare compreso. Sono ormai settimane che si registrano durante il giorno valori oltre i 13/14 gradi, con una copertura del cielo che anche durante la notte, non deponeva certo verso forti escursioni termiche. Insomma un inverno percepito umido ma non certo freddo. Il Mar Mediterraneo, risentendo ancora del calore accumulato nei mesi precedenti (per non dire degli ultimi due anni), segna tutt’ora valori al di sopra delle medie del periodo, con temperature ascrivibili ai mesi di ottobre e novembre. Aggiungiamo che vere e proprie ondate non dico di gelo, ma comunque di freddo in quota non se ne sono viste se non per qualche giorno nell’arco del mese di dicembre e gennaio. Ecco perchè l’inserimento in un contesto mite per la stagione, di un fronte freddo, non “glaciale”, ha creato il combinato disposto per la formazione dei violenti e localizzati temporali. Possiamo immaginare questi fronti come la codina di una frusta,trattandosi poi di vere e proprie (usando un gergo tecnico) fronti terminali in occlusione. I famosi “centri di bassa pressione” come sentiamo dire in tv, erano con i loro nuclei principali fermi sul continente europeo e le fasi terminali scorrendo sun mare ancora molto caldo per il periodo, favoriti dalle condizioni orografiche locali poi nell’interno,hanno creato quella che di solito chiamiamo “rottura stagionale”, e che dovrebbe accadere a settembre… ottobre… non a febbraio.
Un film ormai visto e rivisto, a tal punto che i fenomeni intensi dove si verificano, iniziano ad avere tempi di ritorno molto brevi. Partiamo dall'alluvione lampo verificatasi sull’Isola d’Elba, basta digitare su youtube e vi compariranno video di due anni fa, tre anni fa, sei anni fa… Una delle meno note fu quella su Riomarina, tant’è vero che su facebook si trova anche il post dell’allora sindaco, abbandonato a gestire una situazione usando le sue parole “totalmente imprevista”. Ed ora arriviamo all’empolese valdelsa. Tanto per fare un esempio, su Empoli siamo attorno ai 3-4 anni come tempi di ritorno, che su fenomeni del genere in pieno inverno erano fino a pochi lustri fa, di oltre 15 anni. Basta spostarsi su Cerreto Guidi e ancor più nello specifico su Stabbia e persino la statistica fatica a seguire il susseguirsi degli eventi climatici. Banalizzando forse ulteriormente, ormai è diventata quasi la normalità in un contesto particolare, dove non sappiamo ancora se, ad esempio, in futuro dovremo fare i conti con questi eventi anche più volte in un mese. Sarà il caso quindi di prendere in considerazione il fatto che non si potranno sempre definire eventi straordinari, perchè ormai purtroppo possono accadere più volte in una stagione. Al netto degli interventi che saranno definiti dalle politiche nazionali, starà anche ai consessi regionali e alle autonomie locali, promuovere una cultura dell’autoprotezione, senza terrorismi, ma con la netta affermazione di un progetto generale volto al pragmatismo. E qui però sorge la domanda finale, con quali risorse?